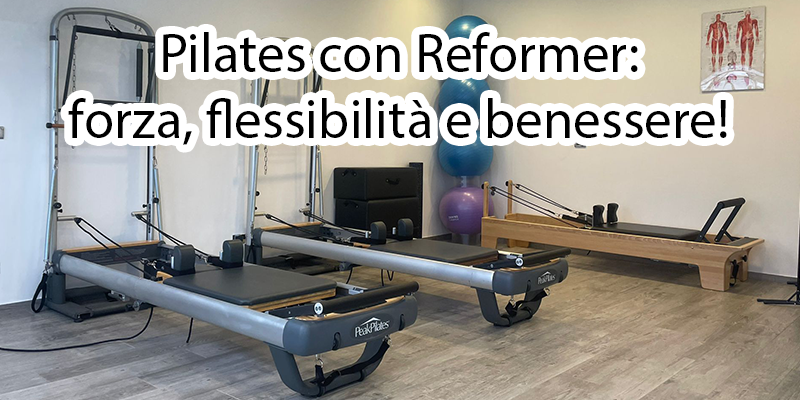In appena due mesi gli italiani che vivevano in Istria, in Dalmazia e nella città di Fiume furono costretti ad abbandonare tutto e a fuggire in Italia. Chi non lo fece abbastanza in fretta venne ucciso dall’esercito di Tito e gettato nelle fosse delle foibe o deportato nei campi di concentramento in Slovenia e in Croazia. Si stima che, alla fine, gli esuli italiani furono almeno 250mila.
Il dramma della popolazione italiana nelle regioni orientali italiane non finì con la fine della guerra, ma solo con il trattato di pace di Parigi con il quale le potenze vincitrici del conflitto decisero che le città di Fiume, Zara così come tutta l’Istria e le isole della Dalmazia fossero annesse alla Iugoslavia. Come se non bastasse, tutti i beni dei cittadini italiani di quelle regioni vennero confiscati. Questo trattato diede origine a una fuga forzata degli italiani da quelle regioni, che abbandonarono praticamente tutto ciò che avevano.
L’Italia riprese il controllo amministrativo della città di Trieste solamente il 26 ottobre 1954, quando la città cessò di essere territorio internazionale.
Secondo le stime degli storici furono tra i 5mila e i 10mila gli italiani uccisi nell’eccidio in Istria e Dalmazia durante e subito dopo la seconda guerra mondiale. Seguì l’esodo giuliano dalmata che durò oltre un decennio. Il contesto, le ricostruzioni e le controversie legate a un fatto storico diventato oggetto di polemiche politiche Agli eccidi seguì l’esodo giuliano dalmata, l’emigrazione forzata della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana in Istria e nel Quarnaro, esodo che si concluse solo nel 1960: secondo le stime, sarebbero tra i 250mila e i 350mila gli italiani costretti a lasciare le loro case.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il vuoto di potere lasciò spazio alla riconquista di alcuni territori da parte dei partigiani jugoslavi di Tito, accompagnata da feroci ondate di violenza che colpirono a vario titolo italiani e non. I comunisti di Tito misero in atto arresti, esecuzioni, deportazioni nei campi di concentramento balcanici. La violenza portò alla morte brutale di migliaia di civili e all’esodo di altrettante persone, persino a guerra finita. Le foibe, una parola dialettale che deriva dal latino fovea (fossa), sono cavità profonde anche decine di metri, tipiche dei terreni carsici. Spesso le fucilazioni avvenivano sui bordi delle foibe, in modo far sparire i cadaveri di migliaia di persone. In molti casi gli italiani venivano legati tra di loro con del filo di ferro, Poi venivano posizionati ai bordi di una cavità e si sparava al primo che cadendo trascinava gli altri compagni di sventura che cadevano sui corpi già presenti da giorni, facendo in modo che l’agonia fosse espressa a livelli incredibili Con l’occupazione jugoslava di Pola, Gorizia e Trieste, nel maggio del 1945, furono deportate circa 3.400 persone di varia etnia. Di queste, più di un migliaio perse la vita in esecuzioni, ma anche in prigioni jugoslave e in campi di concentramento. Al massacro delle foibe seguì l’esodo giuliano dalmata, ovvero l’emigrazione più o meno forzata della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana dalla Venezia Giulia, del Quarnaro e dalla Dalmazia. Quei territori furono infatti annessi dalla Jugoslavia tramite i trattati di pace di Parigi del 1947, firmati appunto il 10 febbraio 1947.
Un atto di violenza politica estrema – Sulla vicenda per decenni è perdurato il silenzio, da una parte per lo scarso interesse della storiografia e dall’altra per motivi diplomatici e geopolitici tra gli stati confinanti. Oggi però la ricerca storica è arrivata a chiarire gli avvenimenti che si susseguirono in Venezia Giulia e Dalmazia negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale. Nonostante questo, le foibe sono oggetto di frequenti polemiche politiche, per via di una ricostruzione che ingigantisce o sminuisce i fatti a seconda della convenienza ideologica. Nei libri i storia, fino a pochi anni fa, delle foibe non su faceva cenno e chi tentava di intavolare una riflessione veniva additato come fascista. Il disegno di legge per istituire il Giorno del Ricordo aveva come primo firmatario Ignazio La Russa, attuale presidente del Senato. L’approvazione, nel 2004, fu comunque quasi unanime con i soli voti contrari di Rifondazione e dei Comunisti Italiani. Il confronto nell’opinione pubblica si riaccende periodicamente
“Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle foibe e dell’esodo hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia”. (Sergio Mattarella)
“Ossa spezzate atroci agonie l’uomo ha superato Caino. Come bestie torturate legati ai polsi con vile fil di ferro gettati ancor vivi nell’oscurità”. (Fabio Magris)
📲 Ricevi gratis le notizie di Montagne & Paesi sul tuo telefonino!
Iscriviti al nostro canale WhatsApp ufficiale per restare sempre aggiornato su notizie e curiosità dalle valli.
📢 Seguici anche su Telegram!
Unisciti al canale Telegram di Montagne & Paesi per ricevere tutte le news in tempo reale.